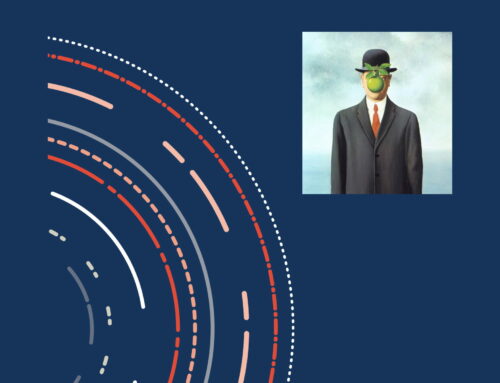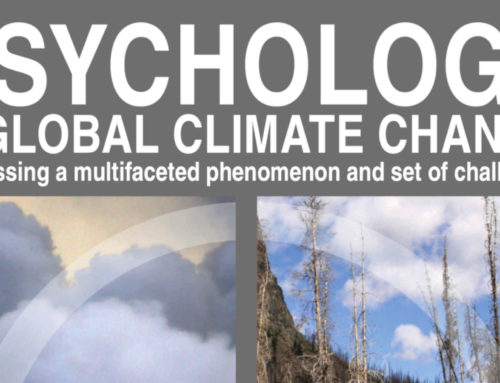Credo che la parola crisi sia ansiogena e fuorviante.
È utilizzata, dagli anni ‘80 in poi in maniera sistematica, per giustificare la tendenza al controllo sociale, all’impoverimento dei risparmi del lavoro delle famiglie.
Inoltre si affianca a questa la promozione del consumismo come base della nuova schiavitù volontaria. Nell’ultima accezione, dal 2008 in poi, l’anticipazione del desiderio verso feticci consumistici ha esacerbato i livelli di controllo degli individui e delle famiglie, con il meccanismo base della schiavitù in cui si perde anche la proprietà del corpo: il debito.
La crisi dei mutui subprime causata dalle banche americane ed il crollo dell’economia riattappato con lo stampare moneta – cioè a spese dei soliti schiavi – ha prodotto ulteriore abbrutimento dei rapporti sociali. Come tamponare questa ulteriore espropriazione dei beni pubblici e privati?
Trasformando in merce ciò che sarebbero i diritti elementari come ad esempio la salute che, appunto, da un diritto diviene merce acquistabile con ulteriore debito. Altrettanto vale per la cultura, per cui i sistemi scolastici pubblici sono sempre più definanziati, e così anche per la ricerca che viene pagata a multinazionali del farmaco, ad esempio.
All’inizio degli anni ‘80 c’era la creazione di una dipendenza da oggetti surrogati dei bisogni reali sostituiti da bisogni indotti per cui, per questo processo, si contraeva e favoriva il debito per l’inutile. Poi piano piano si è cominciato, nello smantellamento dello stato sociale, ad essere obbligati a contrarre debito per l’essenziale per la democrazia: la salute, la scuola, la ricerca, la cultura.
Questa dimensione del debito a qualsiasi livello psicologico (individuale, familiare, istituzionale, comunitario) può essere mantenuta tramite una campagna sistematica di deculturazione della popolazione, una continua immissione massiccia a qualsiasi livello di informazione, di fatto non gestibile da alcun essere umano, idonea pertanto a confondere, a manipolare il consenso senza permettere alcun livello democratico dell’esperienza e della conoscenza.
La vita viene surrogata nelle passioni e nei vissuti dalla partecipazione ad una socialità virtuale inesistente, e ciò permette l’oblio della totale condizione di schiavitù dei corpi e delle menti. Credo sia il contrario della teatralità greca, che permetteva di meglio comprendere il divenire dell’esistenza; stiamo andando verso la sostituzione del teatro alla vita recitando una tranquillità fittizia, disumana.
Quando interviene un evento naturale come un terremoto, un’epidemia, una morte, la mente sociale ed individuale non è attrezzata a questa immissione massiccia di realtà, nessuna resilienza mentale è possibile, essendo la dimensione endiadica della realtà volutamente rimossa in quanto non facilmente vendibile.
Appare pertanto attorno al trauma una dimensione di perplessità esistenziale, si è “sollevato il velo”, si è inceppata la “matrix”.
Lo stato psico-antropologico di questa condizione è ben rappresentato dalla parola spagnola “desesperanza” che non è la perdita della speranza, quanto l’assenza della stessa.
Scrive dal Messico Paolo Pagliai:
No, non è disperazione; in spagnolo esiste una parola meravigliosa, desesperanza, che indica l’assenza e non la lontananza. Non siamo lontani dalla speranza, non abbiamo rinunciato ad essa, solo che la speranza non c’è. E allora, in questo Paese di personas desesperanzadas, non ci resta che dedicarci all’unica cosa che veramente importa: la costruzione della Speranza.
Paolo parla in questa dimensione della Società Messicana, frequentemente in stato di povertà assoluta; per ragioni esattamente opposte, compare da noi analoga povertà psichica in quanto abituati a vivere in una falsa ricchezza.
Credo che un progetto sociale salubre debba permettere una partecipazione democratica collettiva (dialogo psico-sociale articolato nelle fasi della costruzione da persone che sanno fare questo tipo di ricerca-azione), trasformare la complicatezza burocratica in complessità politica, articolare i gruppi di lavoro in una trasparente rete comunicativa, privilegiare la dimensione storico culturale agli “ordini nuovi” che stendono cemento sulle rovine del passato, vigilare sull’umanizzazione dell’ambiente e sull’imprescindibile rapporto con la natura che è parte della società umana stessa. Cercare, infine, di non trasformare il trauma in qualcosa di imprevedibile nel corso della vita, ma restituirlo alla dinamica del cambiamento e della crescita sociale e psicologica.
Tali prassi operative permetterebbero un rientro della speranza come seme del cambiamento, sostituendosi alla dinamica delega-dipendenza-debito che sta alla base della schiavitù.
Massimo Mari